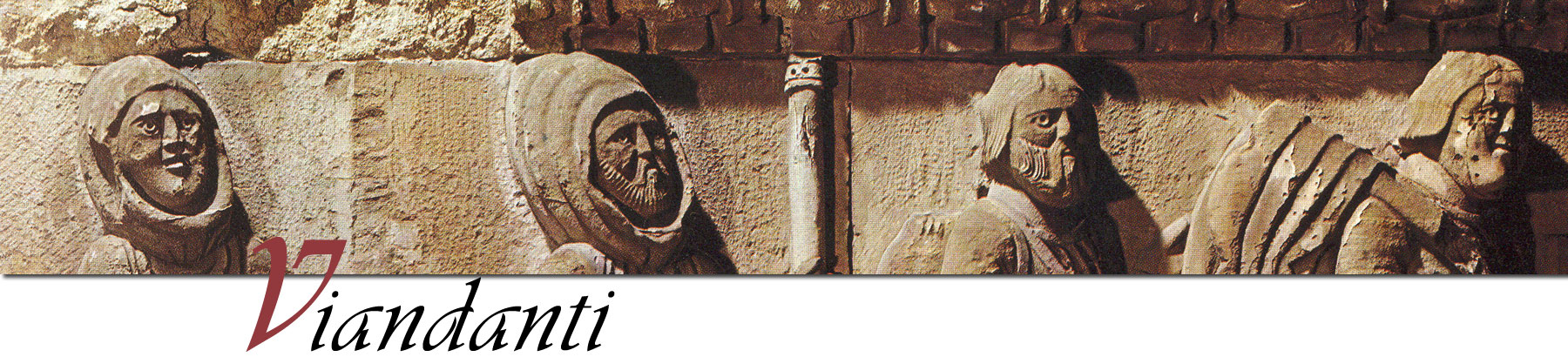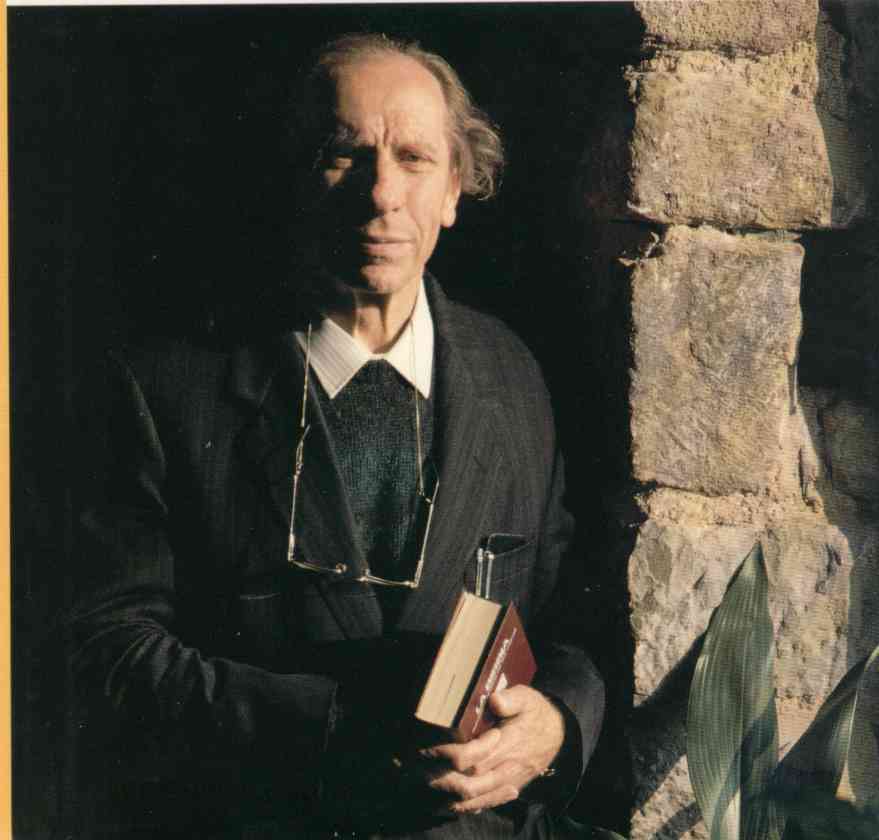
«L’uomo» al centro
Il valore dell’uomo, la sua libertà in ambito storico e la sua salvezza in prospettiva escatologica, l’impegno di umanizzazione della società e della Chiesa: sono stati questi gli elementi fondanti dell’opera e della riflessione di David Maria Turoldo, dal tempo degli studi presso i Servi di Maria agli anni impetuosi della contestazione ecclesiale e sociale successivi al Concilio Vaticano II. A tali orizzonti può essere ricondotta la sua intera vicenda, tesa a restituire al cristianesimo un calore e un sapore di vita, spesso dimenticati in passato nell’aridità di verità astratte e di adesioni intellettualistiche; tesa a restituire alla società una giustizia che la rendesse fraterna e accogliente, in primo luogo per i più svantaggiati e per gli ultimi.
In questa chiave si capisce l’impegno del Servo di Maria nella Resistenza, vissuta non solo nel suo significato storico di cacciata dell’invasore tedesco e di abbattimento della dittatura fascista, ma come vera e propria cesura etica, «scelta dell’umano contro il disumano», istanza di rinnovamento e trasformazione profonda del vivere sociale e civile. Nella Milano dei primi anni Quaranta la spinta ideale in favore dell’«uomo» motivò in lui e nel confratello Camillo De Piaz un instancabile attivismo su fronti diversi e molteplici: l’esercizio di concreta carità a favore di poveri e sinistrati; l’aiuto e l’ospitalità offerti con grave pericolo a oppositori e ricercati, e poi il soccorso a fascisti braccati nei giorni successivi alla liberazione; l’apertura del convento di San Carlo a quanti – superando le contrapposizioni ideologiche e politiche – intendevano predisporre nuove forme di partecipazione democratica e popolare per l’Italia del dopoguerra. «L’Uomo» si chiamò il giornale che, prima clandestino poi autorizzato, uscì dal 1944 al 1946 e a cui collaborarono docenti e studenti dell’Università cattolica maestri e colleghi di Turoldo e De Piaz: Mario Apollonio, Gustavo Bontadini, Dino del Bo, Luigi Santucci, Angelo Romanò. Convinzione comune era che non si potesse formare il cristiano se prima non si fosse «fondato l’uomo», al quale doveva essere restituita la coscienza e la responsabilità delle proprie scelte etiche e politiche.
Insieme agli altri redattori, Padre David guardò sempre alla cultura e al suo libero accesso come allo strumento proprio per l’esplorazione della problematica umana, e caldeggiò l’utilizzo delle sue varie forme di espressione – letteratura, filosofia, teologia, cinema, poesia, pittura – per formare giovani e meno giovani all’esercizio della critica e al giudizio. La sua predicazione era intessuta di riferimenti a opere di cui avrebbe favorito la conoscenza e la divulgazione attraverso le attività della Corsia dei Servi, e poi promuovendo biblioteche e cineforum, nei conventi e comunità in cui veniva inviato dopo l’allontanamento da Milano. F. Dostoevskij, S. Kierkegaard, I. Bergman, C.Th. Dreyer, G. Bernanos, F. Mauriac, J. Moltmann, A. Neher, P.P. Pasolini, D. Bonhoeffer, S. Weil, E. Hillesum: sono solo alcuni nomi di un parterre assai frequentato, nell’intento di cogliere da filosofi a romanzieri, da registi a teologi, quanto stava al cuore delle questioni dell’uomo e del proprio tempo.
La liberazione del cristianesimo
«Credo che da noi dovrà cominciare la grande opera di liberazione del cristianesimo da tutte le coreografie di antica e di recente data [;…] penso che fra cinquant’anni non ci sarà più nulla di tutte queste soprastrutture e di questi ingombri spirituali che hanno solo la virtù di renderci superstiziosi e niente affatto cristiani», scriveva Turoldo al confratello Giovanni Vannucci nel 1949. Quella «liberazione», tentata infruttuosamente nella pur fervida stagione preconciliare, sembrò realizzarsi con il pontificato giovanneo e con il Concilio Vaticano II, con la riscoperta della Parola di Dio che fondava un nuovo radicamento e una nuova essenzialità. Bibbia e Vangelo, letti fin dagli anni Cinquanta in gruppi di approfondimento protesi a interiorizzare una fede acquisita in formulari consuetudinari e asfittici, venivano finalmente posti all’attenzione di tutti e Turoldo non mancò di portare il suo contributo alla presentazione, divulgazione e commento di testi dell’Antico e del Nuovo Testamento.
Non meno importante apparve a padre David il nuovo approccio di dialogo tra Chiesa e mondo che il Concilio inaugurava:
«O il Concilio coincide con la liberazione della Chiesa da se stessa, Chiesa come complesso di sé, come coscienza di “società” in mezzo ad altre società; cioè, o coincide appunto con il “mistero di Dio” secondo la Lumen gentium quale mistero operante in tutta la storia, e quindi si fa coscienza del mondo stesso oltre che coscienza di ogni cristiano come puro testimone di Dio, e allora sarà davvero essa Chiesa sacramento dell’unità, dell’incontro e della pace; o diversamente resterà una “istituzione” fra le tante, con eguale diritto all’ascolto o al rifiuto da parte di tutte le altre istituzioni». (Cfr. D.M. Turoldo, Vera e falsa modernità, in «Servitium», 1[1967], p. 15)
Si trattava di risituare la Chiesa all’interno del cammino dell’umanità, riscoprendola annunciatrice della presenza di Dio per tutti gli uomini, segno di una salvezza a tutti destinata e, in quanto tale, impegnata a perseguire i frutti storici della giustizia e della pace, anticipatori delle promesse escatologiche. Una visione che inquadra l’ideale ampio di ecumenismo che sempre avrebbe contrassegnato padre David: ecumenismo non come concentrazione sui problemi teologici che impedivano l’unità tra le Chiese cristiane, ma come costruzione di quel «sacramento di unità e di pace» che avrebbe dovuto rappresentare la Chiesa per tutta l’umanità, abbattendo ogni steccato, dottrina, privilegio che ostacolasse il servizio all’uomo.
Una visione che spiega la distinzione che Turoldo sempre difese della Chiesa dalla politica – intesa come garanzia di espressione e libertà reciproca -, distinzione che lo conduceva dall’immediato dopoguerra a prendere le distanze dal “partito cristiano” e negli anni successivi ad assumere posizioni favorevoli alla laicità dello Stato quando, come nel caso del referendum sul divorzio (1974), si tentava di imporre per legge una scelta di fede. Il cristianesimo è «nel mondo» ma non «del mondo», avrebbe sovente argomentato sulla base della lettera A Diogneto, chiede che lo Stato rispetti ogni fede ma non che una norma religiosa sia resa obbligante per vincolo legislativo. Una Chiesa non legata al potere, non diffidente della libertà dell’uomo, non appesantita da apparati e precetti avrebbe acquisito una nuova credibilità di fronte ai «fratelli atei nobilmente pensosi», anch’essi in ricerca di un senso del vivere (cfr. la poesia Oltre la foresta, tra le sue più note, in D.M. Turoldo, Canti ultimi, Garzanti, Milano 1991, p. 205).
Il grido dei poveri
Plasmato da un Vangelo liberato e liberante, il cristiano doveva mirare a una efficacia anche storica della propria fede, «perché la parola di Dio è un fatto e non un suono» e la fraternità imponeva che non si dimenticassero le attese di giustizia che si levavano da ogni continente dopo la fine della seconda guerra mondiale e dei colonialismi che per secoli avevano oppresso economie, società, culture. Avendo sperimentato personalmente fame e indigenza per sorte familiare, Turoldo si interessò costantemente dei poveri e della loro elevazione, distinguendo tuttavia la miseria, elemento depauperante e riduttivo dell’umanità, dalla povertà, da lui intesa anche come «più grande maestra», per l’opportunità che gli aveva offerto di apprezzare la bontà dei cibi più semplici, metafora in lui del senso profondo della realtà. L’attenzione ai poveri animò la sua produzione poetica e artistica, e ancor più la sua attività, inducendolo a realizzare, nella Milano del dopoguerra come successivamente a Firenze e a Udine, la Messa della carità, espressione fattiva dell’amore predicato e promesso.
Presto fu l’esperienza di Nomadelfia, la città della fraternità fondata da don Zeno Saltini, che apparve, a lui e a non pochi cristiani “di frontiera” del tempo, paradigma ideale di realizzazione evangelica: «un esempio di come si può prendere il Vangelo alla lettera» – scriveva all’arcivescovo di Milano Ildefonso Schuster – e «una smentita contro quelli che pensano che la parola di Gesù sia un’utopia» (cfr. lettera di Turoldo del 21 ottobre 1949, in ASDMi, lettere a Schuster da religiosi, n. 78097). In favore di Nomadelfia Turoldo avrebbe speso dal 1948 le migliori energie, contribuendo in misura determinate alla sua sopravvivenza economica, fino al proprio obbligato allontanamento dall’Italia per volontà delle autorità ecclesiastiche (dicembre 1952).
Al riscatto dei poveri volle dedicare nel 1962 il film Gli ultimi, da lui ideato e prodotto: il soggetto traeva spunto dalla vicenda autobiografica di una sofferenza infantile che intrecciava lotta contro l’ingiustizia, celebrazione della dignità degli umili, presa di coscienza di un cambiamento e di una liberazione possibili (cfr. D.M. Turoldo, Io non ero un fanciullo, in Id., Mia terra, addio…, La Locusta, Vicenza 1980).
I decenni futuri avrebbero visto padre David protagonista di lotte condivise in favore dei diritti dei poveri in Italia e mondo: dai pulpiti ai teatri, dalle fabbriche alle piazze, molteplici furono gli scenari in cui la sua parola si levò, annunciatrice della speranza ampiamente condivisa di un cambiamento radicale della storia. Negli anni Settanta e Ottanta accolse e promosse le voci della teologia della liberazione latinoamericana – tra cui quella del poeta e monaco nicaraguense Ernesto Cardenal -, intravedendo in essa l’interpretazione esemplare della fede vissuta in chiave di prassi liberatrice; difese la «rivoluzione nella legalità» avviata nel 1971 in Cile dal governo di Salvator Allende attraverso il dialogo delle forze cattoliche “progressiste”, cristiane e marxiste; partecipò alle iniziative del comitato italiano di sostegno al Tribunale Russell II contro le dittature militari insediatesi in molti paesi dell’America Latina. Una figura da Turoldo ricordata con particolare intensità nella predicazione e nei versi fu quella del vescovo salvadoregno Oscar Romero, ucciso il 24 marzo 1980 per le sue coraggiose denunce, da subito riconosciuto come testimone di Vangelo integralmente vissuto, e la cui mancata santificazione appariva a padre David gravissima inadempienza della Chiesa: «Quasi che morire per la giustizia non sia un morire per le opere della fede: quasi che […] senza le opere della giustizia e della pace e dell’amore possa dirsi viva una fede! Cioè, non ci siamo accorti che proprio questo è il segno che una Chiesa è vera e vive: se c’è qualcuno che dà il sangue per il povero, per il popolo di Dio» (D.M. Turoldo, Presentazione a A. Levi, Oscar Arnulfo Romero. Un vescovo fatto popolo, Morcelliana, Brescia 1981, p. 10).
La sfida della pace
Insieme alla giustizia, l’altro cardine della “storia di liberazione” a cui nella visione di Turoldo erano convocati uomini e popoli, era quello della pace. Nella seconda metà del Novecento furono molti i movimenti che si opposero ai conflitti innescati o potenziati dalle politiche delle superpotenze americana e russa. Vaste mobilitazioni internazionali sorsero a favore dell’obiezione di coscienza e dell’obiezione fiscale alle spese militari; contro la guerra in Vietnam (anni Sessanta), l’installazione degli euromissili Pershing e Cruise nella base siciliana di Comiso (anni Ottanta), la guerra del Golfo (1991).
Il contributo di Turoldo si levò anche in queste manifestazioni con la sua predicazione e le sue poesie-ballata come Requiem per il Vietnam, Salmodia contro le armi e Salmodia di Zagorsk, poi confluite nella raccolta poetica più segnata dagli umori e dalle tragedie della storia, Il sesto Angelo (Mondadori 1976). A metà degli anni Ottanta la perestrojka avviata da Mikhail Gorbaciov gli apparve un segno di grande speranza, la promessa del superamento della logica dei blocchi contrapposti, l’avvento di un mondo finalmente libero e unito nella «grande ecumene della Terra» (D.M. Turoldo, Aiutiamo la perestrojka, in «Bozze 89», 5 [1989], p. 79).
Il tema della pace, in Turoldo come nell’amico Ernesto Balducci e in Giorgio La Pira con cui aveva condiviso l’intensa stagione fiorentina, assumeva il carattere emblematico di palingenesi globale, di «utopia che porta avanti il mondo», come egli instancabilmente ribadiva: investiva nuove relazioni economiche, all’insegna della giustizia nei paesi capitalistici e della riscoperta di libertà e democrazia in quelli socialisti; chiedeva la restituzione del diritto alla vita alle popolazioni impoverite; implicava una concezione non depredatoria della natura, perché è impossibile creare pace sulla terra finché non si risolva «il rapporto dell’uomo con le cose». Scriveva a questo proposito nel 1988:
«Quando si legge il comando di “soggiogare la terra” questo va interpretato nel senso che tu la coltivi e la custodisca. Solo così potrà aver fine questo micidiale dispotismo di un uomo che si crede in potere di manomettere ogni cosa. Civiltà nucleare, ingegneria genetica, mani scatenate sulla vita, secondo il principio che sostiene “tutto ciò che è possibile è anche lecito”. Donde questa furia di esperimenti allo stato brado. Forse non facciamo che ingigantire la nostra morte» (D.M. Turoldo, La prima pace, in «Emmaus», aprile-dicembre 1988, ora in Id., Lettere dalla Casa di Emmaus, cit., p. 124).
Parole rivelatrici di un interesse per la problematica ecologica che stava iniziando in quegli anni a svilupparsi nella società civile e nel dibattito interno alle Chiese: a quella Turoldo dedicò in particolare il testo Gufi come angeli, «lettura scenica» rappresentata nell’ambito del convegno di «Bozze» dal titolo Politica e guerra: un divorzio impossibile?, svoltosi a Modena nell’ottobre 1984.
Preghiera come lotta
In un testo pubblicato nel 1981 sulla rivista «Servitium», dal titolo Preghiera come lotta, padre David riepilogava la sua concezione della preghiera. Contestando sulla salda base di episodi biblici gli «stolti […] luoghi comuni» della preghiera come alienazione, ne affermava la «forza operante e irresistibile»; essa veniva valorizzata in una dimensione «storica» e «cosmica» dalla duplice direzione: volta a portare a Dio «gli avvenimenti e le gioie degli uomini» e «di tutte le creature», volta a colmare l’uomo della presenza divina «per esplodere nel tempo e nella storia con la stessa forza di Dio» (D.M. Turoldo, Preghiera come lotta, in «Servitium», 13[1981], pp. 47-52). Parole che illuminano sulla intima convinzione che animava la preghiera di Turoldo ed era a fondamento del suo amore per la liturgia, da interpretare e valorizzare come tempo festoso di canto e d’incontro, esperienza di vita corale e compartecipata, espressione di un popolo protagonista della storia propria e di tutti.
Interessato al rinnovamento liturgico fin dagli anni giovanili, padre David fu spinto dalla riforma conciliare, che nella costituzione Sacrosanctum Concilium proponeva la liturgia come «culmine» e «fonte» della vita della Chiesa e che auspicava la diffusione dei Salmi come preghiera comune del popolo cristiano, a proporre una propria traduzione del salterio. Ne indicava i criteri al vescovo di Bergamo Clemente Gaddi che lo aveva accolto con favore a Sotto il Monte: «1.la massima fedeltà al testo;/ 2.la massima semplicità (nessuna parola che non sia popolare);/ 3.la ri-creazione poetica, per quanto è possibile (la poesia è missione); così che i salmi sono tutti ritmati, musicabili, finalmente (perché la musica è aritmetica e geometria)». Oltre ai Salmi aggiungeva di aver composto «parecchi inni per i vari tempi liturgici: posso insomma essere utile a questa causa, che per me è la più grande, quella di ritornare a pregare con gusto e fede, quella di avere una liturgia più viva e più convincente» (lettera di Turoldo a Gaddi, 12 gennaio 1973; in FT, b. 53).
Turoldo investì moltissimo impegno nella traduzione di Salmi e produzione di Inni che perfezionò e ampliò in diverse edizioni successive a partire dalla prima (cfr. I Salmi nella traduzione lirico-metrica di David M. Turoldo, Dehoniane, Bologna 1973); opera per la quale negli anni Ottanta poté avvalersi delle preziose competenze bibliche e linguistiche dell’amico Gianfranco Ravasi. La speranza che la sua opera fosse assunta dalla CEI andò delusa, nonostante il vivo apprezzamento di Gaddi e i ripetuti tentativi di interessare il vescovo di Crema Carlo Manziana, presidente della Commissione per la Liturgia. Delusione compensata tuttavia dalla riconoscenza di quanti adottarono i suoi testi, per primi i confratelli Servi di Maria, e dall’apprezzamento di Carlo Maria Martini, dal 1980 arcivescovo di Milano, che accostò la sua copiosa produzione a quella degli antichi innografi Efrem il Siro e Romano il Melode (cfr. lettera premessa a D.M. Turoldo, G. Ravasi, Opere e giorni del Signore. Commento alle letture liturgiche festive, Paoline, Cinisello Balsamo 1989). Come auspicava il suo autore, la produzione turoldiana veniva riconosciuta da Martini «quale strumento “musicale”, affinché, terminate le celebrazioni, ognuno ritorn[asse] a casa con la Parola che gli canta[va] dentro».
Poesia, profezia, attesa di Dio
Nell’amore per i Salmi e nella pervicacia con cui si sforzò di renderli fruibili si esprimeva sia l’amore per il testo biblico sia la vocazione alla poesia, sperimentata imperiosamente da Turoldo nel corso dell’intera vita. Una vocazione che assumeva sovente toni e funzione consapevolmente profetici. Suo compito, affermava a più riprese, era il risveglio delle coscienze, il suscitare opposizione all’ingiustizia, la denuncia del «conflitto implacabile tra la realtà com’è e la realtà sognata, invocata, creduta», il dichiarare «la menzogna del mondo»: un mandato in cui la poesia sconfinava nella profezia. «Profeta non è uno che annuncia il futuro, è colui che in pena denuncia il presente», avrebbe scritto negli anni Ottanta, attribuendosi implicitamente il ruolo che gli veniva da più parti riconosciuto (cfr. la poesia Non abbiamo congegni…, in D.M. Turoldo, Nel segno del Tau, Scheiwiller, Milano 1988, pp. 119-120, poi in Id. O sensi miei… Poesie 1948-1988, Rizzoli, Milano 1990, p. 689).
Ma la sua poesia non si caricava soltanto dei toni profetici della denuncia o della esortazione, assumeva più volte le coloriture più intime e sofferte della confessione e dell’interrogazione che dal giovanile “male di vivere” di marca esistenziale si precisava nella inesausta meditazione sull’impenetrabile silenzio di Dio, divenuto tema cardine e assorbente degli ultimi tempi. «Ammalato di Dio», come si dichiarava fin dai primi scritti, non cessò mai di combattere un vigoroso e drammatico “corpo a corpo”, una personale «teomachia» con un Dio nascosto ma di cui non poteva cessare la ricerca. Già nel 1955 aveva espresso con versi dalle risonanze weiliane l’«appuntamento» sempre atteso: «Ma quando declina questo/ giorno senza tramonto?/ All’incontro cercato/ nessuno giunge./ E le pietre bevono/ Il sangue di questo cuore/ Ancora per miracolo vivo» (Dio non viene all’appuntamento, in D.M. Turoldo, Gli occhi miei lo vedranno, Mondadori, Milano 1955, poi in Id., O sensi miei…, cit., p. 229). La sua ultima lirica componeva un incessante itinerarium mentis in Deum che non taceva la tentazione dell’incredulità e si consegnava infine alla fede impotente del Cristo morente sulla croce: «No, credere a Pasqua non è/ giusta fede:/ troppo bello sei a Pasqua!/ Fede vera/ è al venerdì santo/ quando Tu non c’eri/ lassù!/ Quando non una eco/ risponde/ al suo alto grido/ e a stento il Nulla/ dà forma/ alla tua assenza» (cfr. D.M. Turoldo, Canti ultimi, cit. p. 103).
Una poesia-diario, quella turoldiana, sovente più testimoniale che tecnicamente avvertita, che non incontrò sempre il favore dei poeti “laureati” e della critica letteraria, ma apprezzata da una vasta platea di lettori che nella sua voce sentivano risuonare attese, dubbi, interrogazioni, lacerazioni condivise in prima persona. Che nell’impetuoso frate friulano riconoscevano quel «poeta, profeta, disturbatore delle coscienze, uomo di fede, uomo di Dio, amico di tutti gli uomini» a cui andava la gratitudine di Carlo Maria Martini nel corso della cerimonia funebre svoltasi nel duomo di Milano l’8 febbraio 1992.