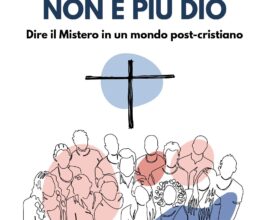RIPENSARE LA STORIOGRAFIA

Viviamo in un presente eterno, dimentichi del passato e poco attenti al futuro. Gli eventi dell’oggi ci travolgono e fatichiamo a collocarli in continuità con il passato o in prospettiva futura. La storia e le storie si frantumano sotto il peso di una quantità di accadimenti ormai ingestibile.
Queste sono le premesse del recente volume di Fulvio De Giorgi, dal titolo Le lacrime di Clio. Storia, sapere e libertà, che, riprendendo l’antico adagio di Orazio — «mentre parliamo il tempo è già in fuga, come se provasse invidia di noi: cogli l’attimo, sperando il meno possibile nel domani» — sembra voler offrire un monito urgente al nostro presente.
C’è un termine che descrive questo “eterno adesso” che caratterizza la nostra epoca: presentismo, ossia la soffocante predominanza del presente sul passato e sul futuro. Non si tratta di un concetto nuovo: coniato nel 1924, è stato analizzato da vari autori, tra cui François Hartog. Il termine racchiude una certa ambivalenza, che gli conferisce profondità: può indicare tanto un fenomeno storico (sul piano sociale e culturale) quanto una questione storiografica (che riguarda la scienza storica e le sue declinazioni).
Tra gli studiosi che hanno affrontato il tema in chiave storica si possono ricordare Eric Hobsbawm, Adriano Prosperi e Marc Augé. A questa condizione ha contribuito in modo decisivo lo sviluppo tecnologico, che ha prodotto una «prevalenza non dello spazio sul tempo, ma del linguaggio spaziale sul linguaggio temporale; e ciò segna il primato del codice (che prescrive i comportamenti) sul simbolico (che costruisce le relazioni).
Scompare il principio di speranza e ciò blocca il futuro» (p. 18). Sul versante storiografico, invece, il presentismo è stato interpretato come un processo di oscuramento della storiografia scientifica.
La teoria della conoscenza storica e la storia sociale e culturale appaiono dunque indebolite da un medesimo processo. Non è un caso che la “Premessa” del volume, significativamente intitolata La storiografia nel Trumpocene, mostri come, con l’avvento da un lato di internet e dall’altro di nuove correnti politiche, si stia assistendo a una proliferazione di narrative divergenti che lacerano il tessuto sociale e spesso mirano alla manipolazione della realtà.
L’opera si propone di «tracciare la storia del presentismo come fenomeno storico (che […] quanto meno sul piano della storia culturale e in particolare della storia della cultura storica, comprende in sé anche il presentismo come fenomeno storiografico). Insomma, si tratta di giungere a una compiuta ed articolata storicizzazione del presentismo» (p. 27).
Strutturata in sette agili capitoli, essa prende le mosse da un’analisi del presente e del tema dell’analfabetismo storico, per poi ricostruire storicamente e teoricamente il concetto di presentismo attraverso un’attenta lettura del nostro tessuto socio-culturale. Particolarmente significativo è il settimo capitolo, dal titolo “La storiografia come resistenza civile”, dove il lavoro dello storico viene interpretato non solo come atto essenziale per la costruzione della società democratica, ma anche come possibile strumento di egemonia sulle altre culture.
L’essere umano è antropologicamente orientato alla narrazione, alla storia e alle storie: il senso storico diventa così questione centrale per l’individuo e per la collettività. Di fronte alla proliferazione di narrative divergenti e alla concentrazione esclusiva sul presente, la resistenza storiografica si rivela un compito imprescindibile. «Il punto di partenza per tale resistenza epistemica è proprio, a mio avviso, l’anti-attualismo (anche come rifiuto di un umanesimo idealistico dematerializzato: in favore invece di un umanesimo “incarnato”. […] Il lavoro di storico, anche e soprattutto oggi, deve sempre essere pure di storico della storiografia – perché la storia della storiografia è radice identitaria del mestiere dello storico – e il problema dell’invenzione (con riferimento ai poteri) della tradizione non va mai scisso dal problema dell’intenzione (con riferimento ai valori) della tradizione» (pp. 112-113).
La resistenza al presentismo e ai nuovi totalitarismi passa dunque, per l’A., da un ripensamento della storiografia e dal rinnovamento del compito civile dello storico, chiamato a riflettere sul rapporto tra invenzione e intenzione e sulla responsabilità della propria opera.
L’immagine di Clio, musa della storia e della poesia epica, richiamata anche nel titolo del volume, è emblematica. Figlia di Zeus, signore del cielo e del tuono, e di Mnemosine, dea della memoria, porta un nome che rimanda al verbo κλείω, “rendere famoso, celebrare”, ed è spesso rappresentata con una pergamena in mano. Le sue lacrime evocano la crisi della storia e della storiografia, ma al tempo stesso indicano la possibilità di un nuovo inizio: la consapevolezza della crisi come premessa di una storia rinnovata, da scrivere e da vivere.
Mattia Vicentini
Fulvio De Giorgi, Le lacrime di Clio. Storia, sapere e libertà, Scholé, Brescia 2025, pp. 160
La recensione è stata pubblicata nel sito settimananews (8 ottobre 2025) con il titolo “Prigionieri del presente”