DIRE IL MISTERO IN UN MONDO POST-CRISTIANO
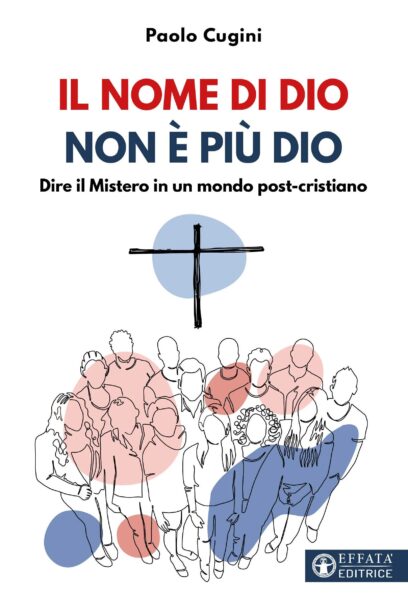
«Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e, allo stesso tempo, più necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per questo profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa» (Evangelii Gaudium n.35).
Quando –alla fine del mese di marzo- è stato pubblicato l’ultimo libro di P. Cugini, e quindi ho cominciato a leggerlo per scrivere questa recensione, papa Francesco era ancora vivo. Dopo la sua scomparsa sentiamo tutti un grande vuoto, dentro, e speriamo che la sua eredità non venga dimenticata; in continuità con il suo insegnamento, speriamo di trovare una Chiesa ancora “in uscita”, missionaria, sinodale, capace di incontrare le donne e gli uomini del nostro tempo nel segno della misericordia di Dio.
Per queste ragioni mi sento commosso e onorato di proporvi la lettura di questo libro, le cui idee sono profondamente coerenti con il pensiero di papa Francesco, che le ha alimentate. Adesso serve più che mai una voce come quella di Paolo Cugini per ricordare quali orizzonti sono stati dischiusi dal papa che proveniva “dalla fine del mondo” e quali sogni, quali progetti possono dare nuova linfa alla vita della Chiesa. Lo dimostra il brano di Evangelii Gaudium posto in apertura: incontrare le persone e far fiorire l’amore è molto più importante che imporre “una moltitudine di dottrine”. Il saggio di Cugini si basa proprio su questa esigenza di ritorno al Vangelo, di semplificazione e di rinnovamento.
Ma per rendere possibile tale ritorno è essenziale la consapevolezza della trasformazione. Raccontando, con la confidenza di un amico, la stagione di vita che sta attraversando, Cugini riconosce di essere cambiato, rispetto al passato, come credente e come sacerdote. Incontri e viaggi missionari, dubbi e riflessioni hanno trasformato il suo approccio alla fede. La rappresentazione tradizionale di Dio, da cui dipendono la dottrina della Chiesa e il suo ordine gerarchico, sembra avere esaurito la propria forza storica, come dimostrano la distanza e l’indifferenza di un numero crescente di persone verso il cristianesimo. La crisi delle certezze tradizionali suscita, certo, un senso di smarrimento, ma può diventare anche l’impulso verso la ricerca di un nuovo senso, verso un nuovo incontro con il volto di Dio. L’epoca del post-teismo, cioè quella in cui la visione tradizionale si dimostra non più sostenibile, è segnata dalla decostruzione, che però a sua volta spinge a un nuovo approccio al Mistero (è così che Cugini chiama questo “Dio da riscoprire”): una ricostruzione nel segno dell’apertura all’altro.
Decostruire, infatti, vuol dire accorgersi che le cose che ci sembravano compatte e solide in realtà sono stratificate e complesse. Sono, spesso, alcuni avvenimenti improvvisi che ci spingono –anche dolorosamente- a interrogarci e riflettere, che aprono spiragli, ferite che possono diventare feritoie. Smascherare le manipolazioni della verità è un disvelamento che produce liberazione e un più autentico contatto con la realtà, ispirato anche dall’amore per la libertà che ciascuno di noi ha in sé. Questo processo poi ci renderà capaci di uscire dai noi stessi per aprirci alle relazioni e al dono (decentramento), lasciando agli altri spazio per essere ed esprimere quello che sono (depotenziamento). Decostruzione, decentramento e depotenziamento si manifestano attraverso azioni deponenti, che cioè rinunciano al predominio per ascoltare e accogliere l’altro. Questo atteggiamento muove dalla convinzione che tutti hanno qualcosa di bello e importante da dare.
Come si osserva, spirano da queste riflessioni un senso di accoglienza e un calore umano che rivelano immediatamente la loro sorgente evangelica. Ma Cugini risale addirittura al modello dei profeti biblici, cioè quegli uomini che, anche a costo di pericoli e sofferenze, non rinunciavano alla ricerca spirituale a cui si sentivano chiamati da Dio. Una ricerca per guardare il mondo da un’altra prospettiva, per cercare orizzonti lontani, per spingere gli altri alla speranza nel futuro. Richiamandosi esplicitamente a due grandi correnti del pensiero moderno, la fenomenologia e l’ermeneutica, Cugini richiama la necessità di saper guardare e prendere in considerazione le manifestazioni della vita, il vissuto autentico delle persone. L’errore di molti cristiani, e spesso anche della Chiesa, è piuttosto questo rifiuto di aprire gli occhi sull’esperienza, nella convinzione che per annunciare il Vangelo sia sufficiente riproporre (o imporre) le dottrine della tradizione, escogitate dagli uomini, senza invece considerare che ogni messaggio, anche quello cristiano, è stato elaborato in uno specifico contesto storico-culturale e va oggi collocato in nuovi contesti storici e culturali, fino a quel sacrario inviolabile che è la coscienza di ogni persona.
Gesù comunicava, attraverso il suo sguardo, interesse per le persone e vicinanza alle loro storie. Lo sguardo è un tema importante in queste pagine. Lo sguardo di amore di Gesù sulle persone, soprattutto sugli ultimi. Lo sguardo dei credenti sul mondo di oggi e sui segni dei tempi. Lo sguardo profetico che Paolo Cugini chiama intuizione, cioè saper cogliere la presenza del Mistero dell’amore in ogni creatura e in ogni cultura (“intuizione” deriva infatti da un verbo latino che significa proprio “osservare”). Se la Chiesa gerarchica ha spesso giudicato il mondo per deduzione, il popolo di Dio oggi è chiamato a incontrare il mondo attraverso l’intuizione, ovvero l’idea (sostenuta già dai primi padri della Chiesa e poi anche dal Concilio Vaticano II) che il Logos ha sparso ovunque i suoi semi vitali -cioè che ogni persona porta in sé la dignità e la scintilla del Mistero. Dio è, così, immanente alla storia e la guida verso la piena realizzazione della libertà e dell’amore, verso il compimento della resurrezione del Cristo cosmico.
Questa visione, apparentemente nuova ma in realtà profondamente radicata nelle Scritture e nei testi dei Padri, sorge dalle rovine della cristianità, cioè la connivenza fra il potere religioso e le norme sociali. La decostruzione della “religione del tempio”, basata sull’esteriorità, è condizione per il passaggio alla vera fede, che è una dimensione interiore. Essa sa cogliere la bellezza di ogni frammento di vita, si prende cura delle ferite e dei limiti, esplora una profondità da cui poi lo sguardo si spinge verso il futuro. Emana un senso di grande consolazione dalle pagine sulla fede e sull’autentica spiritualità, chiamata non a cancellare gli istinti, ma a educarli per farli diventare energia che rinnova il mondo.
La “religione del tempio” ha presentato il rapporto con Dio come compimento rituale di pratiche esteriori che non rinnovano l’animo, e come adesione ad un corpus di dottrine nate dalla convergenza fra mondo giudaico-cristiano e pensiero greco-romano, con le sue categorie filosofiche e metafisiche. L’adesione a queste dottrine è stata spacciata per l’unica strada verso la salvezza e spesso imposta con intransigenza. La violenza storica di ogni colonialismo è l’esito estremo dell’intolleranza dogmatica che poi fonda una religione pervasa da minacce e paure, collusa con il potere. P. Cugini rileva che la teologia scolastica su cui attualmente si basa la Chiesa Cattolica Romana è solo una delle possibili interpretazioni del Mistero e non va più imposta con la forza alle altre culture. Il messaggio cristiano è, invece, talmente universale che deve esserne possibile l’inculturazione, cioè l’innesto nelle culture e nelle sensibilità dei diversi popoli, poiché ciascuno di essi è portatore di bene (in questo consiste il passaggio, o il ritorno, alla monolatria). Immaginiamo che conseguenze può avere questa apertura per le forme liturgiche, che dovrebbero rispettare e promuovere le risorse locali: più che le categorie razionali, sono le espressioni connotative (l’arte, la musica, la poesia) quelle più adatte per avvicinarci al Mistero.
Come si osserva, l’intero testo è costruito come un dialogo costante fra il piano della trasformazione individuale e il piano della trasformazione storica del cristianesimo. La conoscenza umana oggi ci rivela che, nel mondo visibile e in quello invisibile, tutto è interconnesso; persino le nostre identità sono relazionali fin dall’origine. La complessità dinamica in cui viviamo può essere colta solo da una visione olistica ed ecologica: se abbandoniamo il modello antropocentrico –che istiga allo sfruttamento delle persone e del pianeta- possiamo approdare a un senso di appartenenza che genera cura.
Come può allora tradursi questa visione sul piano ecclesiale? P. Cugini auspica che l’umanità si liberi da una Chiesa delle gerarchie e del potere e acceda a una dimensione sinodale in cui il vero protagonista sia il popolo di Dio, come suggerito dalle Sacre Scritture. Accedere alle fonti della Rivelazione dovrebbe consentire a tutti di comprendere che l’esegesi della Parola di Dio è una scuola di libertà che ci fa entrare nella misericordia di Dio. Solo se siamo e ci sentiamo profondamente accolti da Dio possiamo accogliere gli altri con la stessa misericordia; solo se veniamo contaminati dall’amore di Dio possiamo poi contaminare il mondo con il Vangelo e lasciarci contaminare dai germi di bene presenti in ogni individuo e in ogni cultura.
Sul piano della forma espressiva, la prosa di P. Cugini è contrassegnata da paragrafi brevi, concettualmente scorrevoli, e anche da periodi brevi, che talvolta assumono la dimensione di versi poetici. Soprattutto nella prima parte colpiscono il lessico introspettivo e lo stile in prima persona, che creano un lirismo quasi salmico, come nel brano Ti aspetto in silenzio (pp. 25-26), in cui riecheggia il salmo 27 (“il tuo volto, Signore, io cerco”). Sono pagine notevoli che potrebbero essere usate proprio per la preghiera individuale o comunitaria, poiché animate dalla speranza di poter cercare il volto del Signore anche quando il Mistero tende verso una direzione inattesa e sconosciuta. Anche quando il Signore non ci parla più attraverso i segni a cui eravamo abituati, possiamo ancora cercare, nel silenzio, i segni della sua presenza, i segni della risurrezione.
L’aspetto poetico del testo si coglie anche dalle immagini. Fra tutte, spicca quella del fiume, tratta da filosofi antichi, come Eraclito e Marco Aurelio. Nell’immagine del fiume convergono la riflessione sull’esistenza personale e quella sulla storia della Chiesa. Osservare il fiume dà serenità, alimenta l’impressione di un’energia vitale che scorre come se non avesse fine. Eppure, lo stesso fiume ci suggerisce anche l’idea che il tempo della vita passa rapidamente e non ritorna indietro: diventiamo -senza accorgercene- persone diverse da quelle che eravamo prima o pensavamo di essere. Il fiume ci insegna l’arte del cambiamento. Anche la Chiesa, nella storia è cambiata e cambierà. L’acqua che scorre è il Vangelo, sgorgato in alto, da Gesù Cristo, ed è arrivato fino a noi. Ma per esistere il fiume ha bisogno di argini, ed è arrivato il momento di costruire nuovi argini, eliminando in alcuni casi quelli antichi che rischiano di diventare dighe e di imprigionare l’acqua facendone uno stagno.
I riferimenti culturali e bibliografici sono molto ricchi e abbracciano orizzonti di diverso tipo (antropologici, ecclesiologici, esegetici, filosofici, liturgici, patristici, scientifici, sociologici, storici, teologici); intrecciati in modo coerente, essi permettono di proseguire in modo autonomo la ricerca, ma non appesantiscono mai il testo, poiché sono sempre pertinenti alla linea argomentativa e funzionali al discorso.
Nel testo si alternano aspetti formali e aspetti colloquiali: per esempio, le allocuzioni (e ti siedi sul ciglio della strada… p. 27) coinvolgono il lettore dandogli l’impressione di assistere, o di partecipare, a una vera conversazione. In un’ampia gamma di sfumature -dalla passione all’ironia, dallo sdegno alla consolazione, dal rimpianto alla speranza- domina un tono personale che sorregge con continuità il testo e rivela con coerenza che la svolta teologica e la visione della Chiesa ivi proposte affondano le loro radici in un autentico percorso di spiritualità in cui persone anche diverse fra loro potranno riconoscersi.
Ci sono, infatti, messaggi etici e filosofici che possono fare bene ai lettori con una sensibilità più laica (chi si prende cura di sé, chi non ha paura di prendersi del tempo per curare la propria coscienza, lentamente scopre la bellezza della propria vita, i grandi doni ricevuti e mai valorizzati a pieno. È la vita interiore il cammino per il recupero della nostra identità personale. Quando questo avviene impariamo a guardare gli altri, soprattutto le persone a noi più care, in un modo nuovo. Amando noi stessi, apprenderemo ad amare gli altri senza sentimenti di gelosia o di invidia, ma ricolmi di gratitudine. È l’amore a noi stessi che ci libera dai sentimenti negativi di possesso e ci aiuta a valorizzare quello che esiste intorno a noi, p. 59) e messaggi collegati in modo più esplicito alla storia della salvezza (l’invito è all’accoglienza del Vangelo e alla disponibilità al cambiamento, per permettere allo Spirito del Signore di modellare la nostra umanità, per fare in modo che i tratti dell’umanità di Gesù, del suo modo di essere nel mondo, del suo stile nonviolento, della sua capacità di accogliere tutti e tutte senza escludere nessuno, siano riprodotti in noi, p. 123). Non c’è contraddizione fra i due percorsi evolutivi, poiché la rigenerazione dell’umanità è segno della risurrezione di Cristo, verso cui ci sospinge lo Spirito.
Antonio De Caro
P. Cugini,Il nome di Dio non è più Dio. Dire il mistero in un mondo post-cristiano, Effatà, Cantalupa (TO) 2025, pp. 240







