DALLA QUARANTENA ALLA QUARESIMA
Fabrizio Filiberti
È inevitabile darsi ragione della propria fede al tempo del coronavirus. Accanto all’inasprimento delle ordinanze governative che hanno modificato i nostri ritmi di vita (non so se cambierà nel tempo il nostro stile), accanto alle legittime preoccupazioni e carichi di sofferenza che l’epidemia comporta ormai a livello globale, non è mancata la classica polemica intra-ecclesiale.
Il confronto con il passato
Di fronte alla chiusura delle chiese e alla sospensione delle funzioni religiose, da un lato, c’è chi lamenta un cedimento della Chiesa alle ragioni e alla mentalità della società mondana, tirando i remi in barca, rinunciando alla forza della preghiera, alla potenza sanatrice della fede.
Figure anche autorevoli, non tradizionaliste o settarie, del cattolicesimo hanno evocato i tempi andati in cui la chiesa parrebbe aver avuto più coraggio (processioni, preghiere pubbliche, assistenza). Si sono visti elicotteri e preti sorvolare la Lombardia benedicenti con la Madonna in mano, altri celebrare comunque le messe perché la fede protegge dal contagio; vescovi che affidano il momento di crisi alla Madonna, alla Madunina, nonché il Papa pellegrinare solo soletto a qualche altare romano, propiziando il superamento della pandemia. Immagine ben diversa e dimessa dal ruolo egemone affidato all’autorità ecclesiastica in altre drammatiche evenienze!
Dall’altro lato, chi riconosce civilmente doverosa l’obbedienza alle ordinanze, la sospensione di iniziative programmate, la pratica delle cautele personali, compresa la rinuncia all’espressione comunitaria della propria fede: perfino il Papa annuncia che il Triduo Pasquale si svolgerà senza la partecipazione fisica dei fedeli.
Una Chiesa incapace di sfidare il mondo?
Da un lato quindi, l’accusa alla fede ecclesiale di oggi d’essere priva di orizzonti di senso compiuti capaci di sfidare il mondo, far fronte, con l’arma della Croce, della Madonna e della preghiera, alla sventura, ad imitazione dei gesti guaritori del Cristo. Una debolezza spirituale cristiana che è segno estremo di una debolezza più generale dell’umanità contemporanea, nichilista, naturalista.
Una frase sintetizza questa posizione (la traggo, non importa l’esatta citazione, da un intervento presente nel dibattito riportato in questo sito, al quale rimando gli interessati): “La stessa Chiesa (o meglio gli uomini di Chiesa) hanno dimenticato che la grazia di Dio vale più della vita presente. Per questo si chiudono le chiese e ci si allinea ai criteri sanitari e igienici. La Chiesa trasformata in agenzia sanitaria, invece che in luogo di salvezza.”. Sottesa a questa espressione, che dichiara l’“irrilevanza” della Chiesa nell’oggi a vantaggio delle istituzioni mondane, c’è anche la persistente idea che la salvezza sia altra cosa e ben più rilevante della salute, e che oggi la Chiesa le abbia invece parificate, se non perfino ridotto la salvezza ad uno stato di benessere.
Una privazione che ci interpella
Qui occorre una riflessione che indichi come, per la fede, la salvezza dica una modalità di vivere malattia e salute, senza confusione e senza separazione. Chi è guarito, chi riottiene salute da Gesù vive, di fatto, l’esperienza salvifica, nella fede, appunto.
Dall’altro lato, sta la rivendicazione dell’“uomo adulto”, divenuto, con la modernità tecnico-scientifica, capace di riconoscere le cause naturali degli eventi e farvi fronte. Nonché di discriminare la sostanza della fede dai suoi apparati superstiziosi, residui di un infantilismo spirituale che s’accompagna alla sacralizzazione di ciò che appartiene legittimamente – anche per chi ha fede nella creazione – all’autonomia del mondo. In questa direzione, la scelta di chiudere i musei, bar, negozi e le chiese appiana la tipologia dei “servizi” senza discriminare in termini di valore e di necessità proprio nella contingenza presente. L’utenza, secolare o religiosa, si rassegni.
Uno dei punti di convergenza, in entrambe le posizioni, è il sottolineato impedimento dell’accesso all’eucarestia: la privazione della messa, ma anche del sacramento, viatico dei cristiani (#iostoacasa, non richiede infatti bisaccia per il cammino!), appare dirompente rispetto al dettato del precetto. La questione lascia trasparire un’ulteriore domanda sul significato della nostra fede. Discorso troppo ampio per un articolo. Basta focalizzarci sull’essenziale.
Quale fede?
Come intendiamo l’aver fede? Come sentiamo l’esercizio della fede nel vissuto quotidiano? È il rimedio, la medicina, la profilassi, l’atto risanatore dei mali? È il gesto magico-sacrale rivolto al “Dio tappabuchi”, l’estrema risorsa di fronte alla fragilità e all’errore umano (antesignano del Super-eroe moderno)?
Oppure è il riconoscimento, nella vita di Gesù di Nazaret, di una potenza sovrana, di una sovranità (quella che il Vangelo chiama “Regno di Dio”) capace certo di prodigi e di guarigioni? Di incredibili comunanze di vita, costruzioni di giustizia, di perdono reciproco; di gesti di soccorso, mutuo aiuto, opere di bene comune, dono gratuito di sé fino al sacrificio, fino al martirio – inteso, letteralmente, come testimonianza della propria fede in Dio e/o della propria fede nell’Uomo.
Anche capace di segni (va ricordato questo aspetto presente nei vangeli), cioè di opere il cui valore non sta tanto nella loro efficienza ed efficacia fisica, immediata, ma nell’attestazione di un orizzonte entro il quale si può accedere superando il confine, sperimentando una modalità del vivere nella quale conta il senso, la verità, nonostante il trauma vivente da cui proveniamo.
Il bisogno di piantare la tenda
Il rito è questo: passaggio da “questo mondo” al “mondo non di questo mondo” (per usare un fraseggio giovanneo). Nessuna contrapposizione tra aldiqua e aldilà! Passaggio, piuttosto, dal non essere pienamente nel mondo (cioè capaci di sopportarlo) all’essere in grado di assumerlo, facendoci pienamente cittadini del mondo.
Questa è l’autentica “liturgia” da compiere (letteralmente: l’opera del popolo). Tutti insieme, mai isolatamente, sentiamo il bisogno, ogni tanto, di piantare la Tenda – come Israele nel deserto – e accogliere la Parola che viene nel luogo Santo, anticipo di quanto, nel cammino, ci manca e desideriamo.
C’è da chiedersi se i flash mob cui abbiamo assistito (canti corali, battimano globali) al motto “andrà tutto bene” non siano l’ultima secolarizzazione del rito comunitario: sviluppo laico dell’esorcismo, dei riti propiziatori e apotropaici (scaccianti i mali), dell’eucarestia (ringraziamento e preghiera perché tutti siano uno). Potendovi aderire dal proprio isolamento, hanno avuto una risposta immediata, facendosi appuntamento rituale (ore 18,00, non si può tardare…!).
Mancanza e sostanza del rito
Non dimentichiamo che ovunque – pur in assenza di pubblico “in chiesa”, ma si spera presente “a casa”… – l’eucarestia è stata celebrata. Dovrebbe essere apparsa evidente, e il credente potrebbe averla sperimentata, pur nella povertà dell’isolamento e talvolta della solitudine, la potenza salvifica che la partecipazione a quella messa ha saputo produrre.
A fronte di un precetto domenicale per molti privo di appeal e di senso, queste messe on line ci hanno probabilmente fatto sperimentare la mancanza, ma anche la sostanza del rito. Esso non è mai un atto magico, un luogo di riversamento di improbabili richieste, che rimandano piuttosto (e, positivamente, sollecitano) alla propria responsabilità.
Il rito è il luogo e il tempo della memoria, dell’indicazione di quel orizzonte che indica la via, lo sguardo adeguato sull’oggi vissuto. Sosta in un cammino quotidiano che, pur potendo procedere autonomamente in forza delle nostre scelte, chiede ogni tanto (ecco la sapienza della ritualità) di accedere ai fondamenti del camminare, al motivo che ogni giorno ci fa alzare, uscire, operare, rincasare.
La privazione forzata della pienezza di questa dinamica esistenziale ci riporta a riscoprire lo spazio di quel “perché” e il luogo in cui risuona la possibile risposta: l’ascolto di una Parola che è sempre di vita e mai di morte, la partecipazione ad una Comunione di cuore e di spirito, la spinta rinnovatrice e sanate dell’Agape fraterna al di là degli steccati e dell’anonimo individualismo che ordinariamente ci abita. Qualcosa come un flash mob “divinumano”, direbbero i fratelli Ortodossi!
“Signore vieni presto in mio aiuto”
In questa direzione, la necessità di ritornare ai luoghi reali di condivisione, dove sperimentare senso e vicinanza, relazionalità fatta di corpi e di gesti – che scopriamo oggi mai scontati e banali, nemmeno nella loro routinaira esperienza –, appare un kairos, un momento di grazia: si tratta di passare dalla quarantena alla quaresima, guarda caso a quel rito (per molti stantìo) che prevede lunghi giorni di conversione di sé, dalla mentalità scontata ed efficientista del tran tran quotidiano, alla scoperta, in esso, dei motivi di fondo del vivere, capaci di guarire dalle ferite e di offrire significato alle ore: salute e salvezza, appunto.
A queste condizioni anche l’auspicabile apertura delle chiese alla visita privata, pur senza funzioni – come il Papa ha ancora una volta esemplificato – mantiene la sua valenza devozionale: luogo di parole e gesti essenziali che, se non altro, dicono l’affidamento che il credente fa della propria vita al suo Signore.
Annota Andrea Grillo, liturgista: “E possiamo e vogliamo ancora cantare “O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto”, senza doverci per questo vergognare di avere il libretto sanitario”.
Fabrizio Filiberti
Presidente di “Città di Dio” Associazione ecumenica di cultura religiosa – Invorio (NO). L’Associazione “Città di Dio” aderisce alla Rete dei Viandanti.
Membro del Gruppo di riflessione e proposta (Grp) dell’Associazione Viandanti.
[Editoriale online dal 21 marzo 2020; credito immagine: Ansa]
Nel sito, altri articoli correlati:
F. Filiberti, Non di solo pane (eucaristico) vive l’uomo…

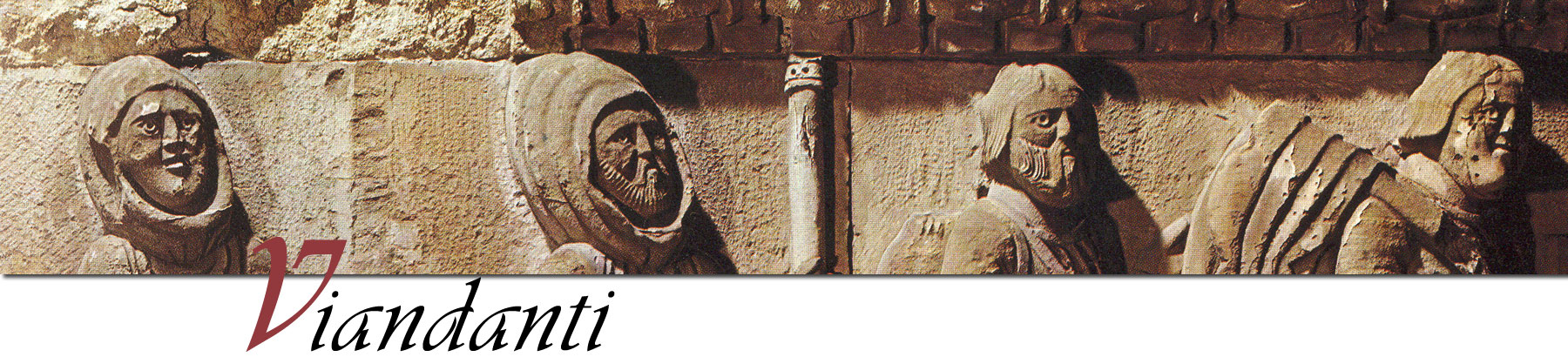






La riflessione di Fabrizio Filiberti è problematica, e per questo molto interessante. Questi giorni, di città e di chiese deserte, di bocche e di mani che non possono toccarsi, possono essere un tempo di educazione a una politica e a una fede vissute con partecipazione più autentica. All’appuntamento siamo stati catapultati gravati da un tasso di spoliticizzazione e di ritualismo crescenti. Io vedo nell’isolamento una “resa” obbligata alla potenza del virus, in dialettica con la “resistenza” in pensieri, parole, comportamenti che stiamo già sperimentando. Se Dietrich Bonhoeffer era chiuso in carcere in attesa di essere giustiziato, noi siamo chiusi in casa in attesa di ri-incontrarci nelle città e nelle chiese. La preghiera che i credenti rivolgono a Dio è di domanda, ma non perché cambi lui, che sta soffrendo con noi, ma affinché cambiamo noi. In cammino verso un mondo in cui “verità e pace si abbracceranno / giustizia e amore si baceranno” (Salmo 85, 11).
A complemento segnalo che il giorno 21 alle 9.30, a Uomini e profeti, Daniele Menozzi ha ricordato che anche in passato uomini di chiesa si sono adeguati (ovvero ne hanno preso l’iniziativa, come il papa a Roma per una epidemia di colera nel 1830 se ben ricordo) a normative “civili” di divieto di professioni e benedizioni per prevenire il contagio.