“LITURGIA DI POPOLO”
E DIVERSITA’ MINISTERIALE
Cesare Baldi
Il termine “liturgia” deriva dal greco λειτουργία, che significa letteralmente “azione per il popolo”, composto da lḗiton (λήιτον), il “luogo degli affari pubblici” cioè del popolo (λαός), e ergon (ἔργον), l’opera, il lavoro, l’attività. L’antica Grecia prevedeva liturgie civili, militari e cultuali; in tribunale, quando ci si alza in piedi perché entra la corte, vestita di solenni toghe nere, si sta propriamente celebrando un rito, una liturgia civile, un’azione di popolo con le sue regole, i suoi ruoli e i suoi tempi. Quindi l’espressione “liturgia di popolo” è una tautologia, perché una liturgia richiede per definizione una partecipazione corale, di popolo.
Una doppia lamentela
L’uso corrente del termine in ambito ecclesiale non corrisponde però esattamente alla sua etimologia, specie quando il popolo, cioè l’assemblea che celebra, è ridotto a pochi elementi e la celebrazione rischia di essere povera, priva di una partecipazione multiforme e ricca di interventi distinti e appropriati: preghiere, riflessioni, espressioni canore o danze rituali. La liturgia si riduce così a poco più che un’azione individuale del “celebrante”, altro termine usato di frequente nelle nostre canoniche, che immediatamente separa chi celebra da chi assiste.
È ovvio che in un’assemblea liturgica non tutti possono svolgere le stesse funzioni, ma il senso stesso della riforma liturgica sta proprio nella partecipazione “piena, attiva e comunitaria” di tutti i fedeli presenti (cf. SC 21) ed è assai deprimente quando i testi liturgici prevedono tra chi presiede e l’assemblea un dialogo che incespica invece di scorrere, si perde o scompare. Si assiste così a una duplice lagnanza: da una parte i presbiteri lamentano il poco senso di partecipazione dei fedeli e dall’altra questi ultimi deplorano la mancanza di oratoria dei primi.
Il fatto è che spesso ad entrambe le parti mancano gli strumenti per intervenire in maniera adeguata: i presbiteri hanno concentrato la loro formazione sugli aspetti contenutistici del dato rivelato e sulla riflessione che ne è scaturita nei diversi ambiti di studio (teologico, esegetico e morale), senza acquisire particolari competenze a livello metodologico, su come si anima una liturgia, anzi spesso lasciando all’esperienza “sul campo” il compito non facile di conseguire una modalità comunicativa e organizzativa efficace. Il risultato è dunque molto vario e dipende necessariamente dal carattere e dalla natura personale del singolo prete.
D’altra parte i fedeli, sprovvisti di un’adeguata formazione relativa al loro ruolo di adulti nella fede, chiamati ad esercitare consapevolmente il proprio sacerdozio comune anche durante la liturgia, sono ancorati in genere alla loro percezione ecclesiale risalente al periodo dell’infanzia e legata ai sacramenti dell’iniziazione e alla catechesi ad essi funzionale e spesso non trovano neppure lo spazio per poter esercitare quel sacerdozio di cui sono investiti.
L’affermazione del sacerdozio comune
Le indagini sociologiche sulla religiosità in Italia notano un incremento del senso del sacro negli ultimi decenni, ma non è facile cogliere se in area cattolica ci sia una chiara e condivisa coscienza di essere «una stirpe eletta, un sacerdozio regale, un popolo santo» (1Pt 2, 9), di appartenere, cioè, a una collettività chiamata a partecipare attraverso il battesimo della stessa natura sacra.
Difficile sapere quanti conoscono e condividono il passaggio della costituzione dogmatica Lumen gentium sul comune carattere sacerdotale di tutti i battezzati, che prevede che «tutti i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio, offrano sé stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio, rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza che è in essi di una vita eterna» (LG 10).
Il compito è immenso, stupisce perciò che il Codice di diritto canonico non affronti neanche lontanamente l’esercizio di tale sacerdozio e lo citi solamente una volta (al can. 836), per affidarlo alla cura assidua e illuminata dei «ministri sacri». Cosa quindi comporti in realtà «il culto cristiano in cui si esercita il sacerdozio comune dei fedeli» (come dichiara lo stesso can. 836) non è chiaro. Nel testo della Lumen gentium però sono «tutti i discepoli di Cristo» a offrire sé stessi e non solo ad essere oggetto delle cure assidue dei pastori.
Questa prospettiva sembra sfuggire al diritto canonico e ai commentari del testo conciliare, che peraltro si sono invece soffermati, facendo scorrere fiumi d’inchiostro, sul passaggio che sottolinea la differenza essenziale tra il sacerdozio comune e quello ordinato (cf. LG 10). Essa non comporta però una sovrapposizione gerarchica di quest’ultimo sul primo ma si fonda sulla diversità delle vocazioni, cioè sulla specificità delle missioni a cui ciascuno dei due è destinato.
Al sacerdozio comune, perciò, è chiamato ogni battezzato, che deve poter esercitare il suo ministero con convinzione e cognizione di causa, senza incertezze a livello dottrinale, giuridico e pastorale. Insistere sulla differenza ontologica delle due forme di sacerdozio non può che ingenerare confusione sull’autoconsapevolezza dei fedeli, nonché sulla loro vocazione e sulla loro missione. Quale coscienza possono avere i cattolici sul loro ruolo di membri attivi del popolo di Dio e sulla loro partecipazione al sacerdozio di Cristo, se non è ancora chiaro cosa comporta questo carattere sacerdotale e come si integra con il sacerdozio ordinato? Difficilmente potranno assumere il proprio ruolo, testimoniare con efficacia il loro battesimo e “rendere ragione della speranza in una vita eterna”, senza una riflessione in merito.
Valorizzare la diversità ministeriale
Come viene esercitato dunque il sacerdozio comune nelle celebrazioni liturgiche? Per poter rispondere in modo adeguato, facciamo una breve digressione sulle figure portanti di una qualsiasi liturgia, nel senso di un’azione di popolo, come può essere una rappresentazione teatrale: in ogni messa in scena ci sono due parti fondamentali da ricoprire, una evidente e l’altra nascosta, il/la protagonista e il/la regista. Succede a volte che i due ruoli coincidano, ma normalmente sono distinti.
Nelle nostre celebrazioni liturgiche questa percentuale è rovesciata: di norma il protagonista accentra su di sé anche tutte le responsabilità della regia, arrivando ad essere l’unico attore e addirittura a ridurre la celebrazione ad un monologo talmente autoreferenziale da risultare inudibile. Occorre, e a nostro avviso è urgente, ritrovare il senso della celebrazione comunitaria come frutto di un’opera collettiva e non più solo come esito della volontà individuale del clero che presiede: occorre cioè “declericalizzare” la celebrazione, o meglio “ricomunitarizzare” l’azione liturgica. La comunità di fedeli deve poter ritrovare il suo ruolo, come soggetto plurale, nella realizzazione e nella regia della celebrazione.
Una liturgia “di popolo” è un momento complesso, articolato in diverse parti, che hanno ciascuna una sua importanza e che costituiscono un sistema articolato, che in genere comprende l’ingresso, l’accoglienza, l’animazione canora, la lettura della Parola di Dio, la raccolta delle offerte, la processione offertoriale, il servizio all’altare, la preghiera universale, le intenzioni per i defunti, le intercessioni per i vivi, gli avvisi, il commiato, senza contare quel che prepara il momento liturgico, come le prove di canto o semplicemente il suono delle campane, e quel che segue, come lo scambio dei saluti o l’eventuale momento di condivisione.
Tutto ciò richiede una certa capacità organizzativa e un’indubbia disponibilità partecipativa dei fedeli: una liturgia curata in ogni dettaglio ha ovviamente un’efficacia e un impatto ben maggiore che una celebrazione improvvisata, fatta in fretta, perché magari il prete deve correre altrove per celebrarne un’altra e la liturgia si concentra nel momento eucaristico. Si può ridurre al minimo il suo svolgimento, ma azzerare il coinvolgimento del popolo significa snaturarla. Un numero talmente esiguo di fedeli da non arrivare neppure a prevedere una partecipazione corale, con interventi diversificati almeno nelle letture, mette in seria discussione la celebrazione liturgica, nonché l’esistenza stessa della parrocchia o della cappellania in questione.
Un’azione intenzionale e non opzionale
Ammesso dunque che ci siano i numeri per un’effettiva liturgia, cioè un’azione di popolo, occorre non soltanto che questo stesso popolo si renda disponibile a svolgere gli incarichi che il “celebrante” richiede, ma si appropri della celebrazione, si senta protagonista e assuma ruoli precisi, rivesta cioè la funzione sacerdotale che gli spetta e affidi, in accordo con chi presiede, i servizi necessari a chi è in grado di svolgerli per capacità proprie, competenze o doni particolari.
La tradizione ecclesiale prevede da secoli due particolari servizi, riconosciuti e istituiti come “ministeri”, a cui di recente papa Francesco ha ammesso anche le donne: il lettorato e l’accolitato (cf. il motu proprio del 11 gennaio 2021, Spiritus domini). È interessante notare che, per farlo, il papa abbia dovuto correggere il Diritto canonico, che invece permetteva l’accesso a tali ministeri solo ai “laici di sesso maschile” (cf. can. 230, §1). Il documento offre nell’introduzione un’utile nota sintetica sul significato stesso dei ministeri in rapporto al popolo di Dio. È la Chiesa a riconoscere i carismi e istituirne alcuni come ministeri, altri come sacramenti e altri ancora «mediante un rito liturgico non sacramentale», dunque l’Ordine rientra in questo processo di sviluppo ecclesiale e ne è un effetto.
La valorizzazione dei ministeri è quindi un riconoscimento dell’azione dello Spirito nella comunità cristiana e, viceversa, un loro accantonamento o addirittura il loro discredito è una colpa nei confronti dello Spirito Santo. In ogni comunità di fedeli, in ogni parrocchia, non dovrebbero quindi mancare i lettori e gli accoliti, sia uomini che donne, così come dovrebbe essere prevista un’altra figura ministeriale: il/la catechista, che papa Francesco ha riconosciuto come ministero istituito col motu proprio del 10 maggio 2021, Antiquum ministerium.
Promuovere l’assunzione di questi ministeri nel popolo di Dio non può essere opzionale, se si vuole far crescere la consapevolezza dei suoi membri di farne parte.
Cesare Baldi
Presbitero della diocesi di Novara. Direttore dell’Istituto di pastorale dell’Università Cattolica di Lione
[Pubblicato il 21.9.2023]
[L’immagine che correda l’articolo è ripresa dal sito: https://focolareliguria.altervista.org]

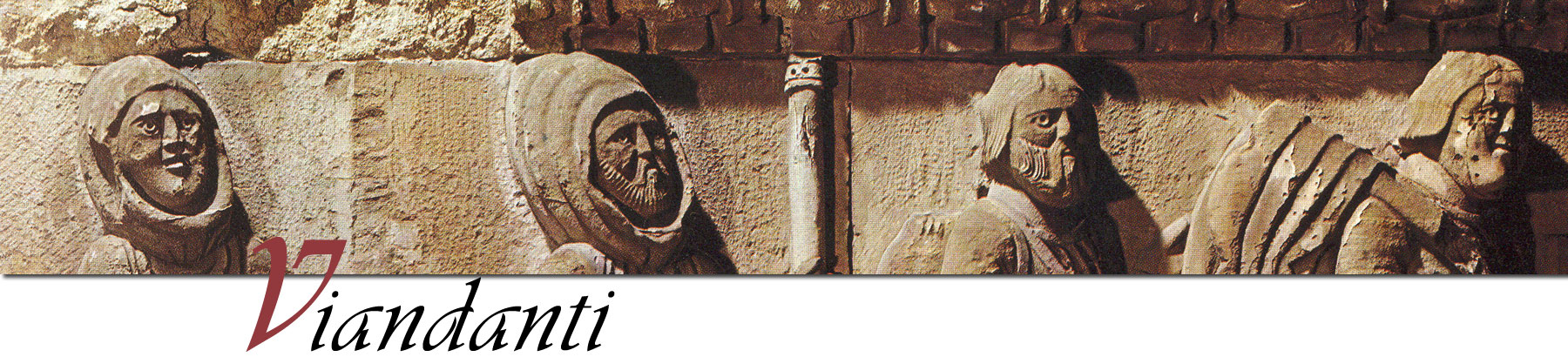






Anche io condivido le osservazioni di Giancarlo Martini. Aggiungerei solo due cose:
1) la messa come è strutturata sembra ottima per grandi e anonime assemblee. Mentre per comunità di dimensioni umane invita ad allenarsi.
2)volendo dare una dimensione mistica, non irrispettosa, se è l’incontro dell’anima con l’amato pare un percorso dove raggiunto l’apice si termina con una sigaretta.
Mentre chi si ama davvero si abbraccia lungamente.
Come tradurre questo sarebbe oggetto di nuovi rinnovamenti liturgici che avverranno forse tra alcuni secoli o in cielo.
Nel frattempo forse basterebbe un pò di matura libertà per le piccole assemblee. Proseguendo la direzione tracciata dal Vaticano secondo.
( li fece sedere a gruppi di 50, cito a memoria)
Le gerarchie ecclesiastiche, i consacrati, dove li troviamo nel Vangelo? Troviamo l’esatto contrario.
Un grazie all’amico Cesare per le sue riflessioni, che condivido. Mi resta però l’impressione (dimmi se sbaglio) che non sia messo in luce sufficientemente il fatto che la celebrazione è prima di tutto una memoria, fatta sì di parole e riti, ma prima di tutto di rapporti interpersonali che riproducono il rapporto che Gesù ha avuto con il Padre e con i suoi discepoli. Il presidente (lasciamo da parte il termine sacerdote) è tale solo perché è pastore, cioè incaricato di sviluppare tali rapporti, che dovranno poi riversarsi ed espandersi nella vita quotidiana dei fedeli.
Ho letto con interesse ma anche con tanta amarezza, senso di impotenza e molteplici interrogativi l’editoriale del presbitero novarese Cesare Baldi.
Le mie considerazioni, svolte già in altre occasioni, non sono di tipo astrattamente speculativo ma scaturiscono dall’esperienza vissuta all’interno di una piccola comunità che ha camminato ininterrottamente per 50 anni nel rinnovamento della liturgia fino allo stop impostoci due anni fa.
La doppia lamentela di cui parla l’autore dell’articolo (“da una parte i presbiteri lamentano il poco senso di partecipazione dei fedeli e dall’altra questi ultimi deplorano la mancanza di oratoria dei primi”), se può valere per tante realtà, certamente non vale per la nostra, per la quale le lamentele sono esattamente di segno contrario. È stato il nostro nuovo presbitero-parroco su indicazione del vescovo, prima ancora dell’ingresso in parrocchia, a lamentarsi della eccessiva partecipazione dei fedeli (ci è stato impedito di proseguire l’importante lavoro di rinnovamento del linguaggio liturgico, ci è stato impedito, dopo una esperienza decennale, di prendere la parola per offrire un nostro contributo sulle Scritture proclamate…). Pertanto le nostre lamentele non riguardano evidentemente l’oratoria di chi presiede. Oggi ci lamentiamo perché l’eucaristia domenicale non è più un momento significativo e importante per chi vi prende parte e molti ormai stanno disertando. E sono lamentele intrise di tanta amarezza ricordando ciò che scriveva proprio il nostro vescovo (quello di Novara!) nel 2010, indicando la prima eredità del concilio nel passaggio «da una comunità “del sentir messa”, ad una comunità che “celebra”» (Il Concilio Vaticano II, “bussola” per la Chiesa).
Mi stupisce sempre constatare che molte riflessioni sulla liturgia difficilmente partano da quella cena di cui siamo chiamati a fare memoria, da quella tavola al piano superiore di una casa attorno alla quale Gesù insieme alla piccola comunità dei suoi discepoli ha compiuto il gesto della frazione del pane, segno di vita donata e condivisa.
Se si partisse da quella cena difficilmente si potrebbero invocare assemblee particolarmente numerose come precondizione per una eucaristia “riuscita”.
Solo in una comunità non troppo estesa è possibile del resto una maggiore partecipazione di tutti, dal prendere la parola, allo svolgere tutti molte mansioni e compiti.
E inoltre in una piccola comunità non è necessaria la moltiplicazione di ministeri istituiti o non istituiti: tanti possono leggere, tanti possono distribuire l’eucaristia…. La fissazione di compiti specifici può comportare una certa clericalizzazione e favorire la mentalità della delega così diffusa nelle nostre comunità ecclesiali e non solo.
All’interno di una visione sinodale in cui il primato è quello del “noi ecclesiale” la preoccupazione fondamentale è quella di diventare tutti soggetti dell’azione liturgica, come si afferma giustamente nell’articolo, e non quella di stabilire rigidi incarichi. E quei vari ed eventuali ministeri liturgici che emergono dalla vita della comunità hanno il compito non di sostituirsi ma di favorire la partecipazione di tutti.
Altre osservazioni potrebbero essere fatte su tempio e/o casa, su tavola e/o altare. Ma qui mi fermo.
gincarlo martini
Condivido le osservazioni di Giancarlo Martini per una declericalizzazione della liturgia.